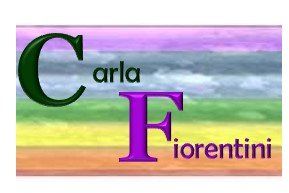Ribaltiamo i modelli mentali - Accoglienza
Ribaltiamo, e svisceriamo, uno dei termini più belli e più complessi che esistono: accoglienza.

Per il vocabolario dell’enciclopedia Treccani accoglienza è l’atto di accogliere, di ricevere una persona.
Un po’ limitativo, secondo me, ma poi rimanda al verbo accogliere e amplia il discorso.
- Ricevere, ricevere nella propria casa, ammettere nel proprio gruppo, soprattutto con riguardo al modo, al sentimento, alle manifestazioni con cui si riceve
- Ricevere, sentire, accettare (notizie, proposte, richieste) con un determinato atteggiamento o stato d’animo
- Riferito a un luogo, a un ambiente, ricevere in sé, anche offrendo rifugio o ospitalità
- Raccogliere, radunare, riunire
Ciascuno dà al termine accoglienza un significato principale, che gli risuona più di altri.
Per me l’accoglienza è un valore del femminino, e di questo sono abbastanza sicura, e riguarda l’accettazione del nuovo e del diverso.
Ma già scrivendo queste parole scatta una riflessione: il nuovo è abbastanza chiaro, ma il diverso?
E mi viene in mente il titolo di un bel film italiano di qualche anno fa: Diverso da chi?
Già, perché nessuno è davvero, totalmente, uguale ad un altro, e la diversità appartiene, fortunatamente, a ciascuno.
Cominciamo parlando di persone, e andando sul pratico.
L’arrivo di una nuova persona in un’azienda.
- I valori femminili di accoglienza e inclusione fanno sì che qualunque nuovo arrivato sia accolto “a braccia aperte”, invitandolo ad esprimere opinioni, a suggerire cambiamenti, a portare novità, nuove idee, nuove procedure, nuovi progetti. Le energie maschili dell’esclusione e del mantenimento dello status quo fanno invece sì che il nuovo arrivato venga indirizzato all’acquisizione dei valori e delle procedure esistenti in azienda.
- In entrambe i casi chi arriva può essere accolto bene o male (sì, anche l’accoglienza a braccia aperte può essere sgarbata), può essere accettato o respinto dal sistema esistente. Dove prevale l’energia femminile si chiede al nuovo arrivato di essere artefice di cambiamenti. Dove prevale l’energia maschile si chiede al nuovo arrivato di acquisire ciò che già esiste.
C’è anche confusione tra accoglienza e inclusione,
spesso usati come sinonimi. Non lo sono, per quanto abbiano similitudini.
Le differenze sono evidenti se, ad esempio, parliamo di immigrazione.
Abbiamo i centri di accoglienza, ricoveri più o meno temporanei, ma è chiaro che l’inclusione richiede molto di più.
- L’accoglienza può essere fatta da superficiali amici su facebook o su altri social network finalizzata a raggiungere “1000 amici – 5000 follower, …” o dall’acquisto dell’ultimo modello di qualunque cosa senza valutarne l’utilità e men che meno la necessità. Ci sentiamo accoglienti nel rimuovere ostacoli all’immigrazione, a patto che, poi, i figli degli immigrati non frequentino le stesse classi dei nostri figli. Ci sentiamo innovatori viaggiando per il mondo, accoglienti perché andiamo nei Paesi poveri, ma poi cerchiamo villaggi italiani che servano spaghetti a pranzo e cena.
Argomentando di accoglienza e inclusione è fin troppo facile arrivare al problema del bullismo, fenomeno fin troppo frequente, ma io desidero fermarmi prima, al quotidiano, senza arrivare alla patologia.
L’accoglienza è un primo passo: accettare, non respingere.
Vale per le persone e per le idee. Si rifiuta l’accoglienza a persone che vengono viste come diverse, si rifiutano le idee che vengono vissute come strane.
Per includere, però, è indispensabile fare un passo in più: cambiare.
L’esempio più semplice che posso trovare è relativo ad un’idea. Posso accogliere un’idea, accettarla, riconoscerla anche come valida. Poi… Gaber diceva che bisogna mangiarla per fare la rivoluzione. Sì, perché per includere un’idea devo farle spazio, spostare le altre idee. Pensate ad un progetto, nuovo, che accogliamo in quanto valido: ci piace. Non basta per renderlo realtà: deve trovare posto nella nostra pianificazione, probabilmente devo cambiare i miei piani, modificare, integrare.
E le persone?
Io vedo due elementi in gioco.
Il primo è riconoscere l’unicità, e quindi la diversità, di ciascuno. Richiede una mappa del mondo flessibile, una zona di comfort ampia, empatia, intelligenza emotiva. Richiede anche una visione del mondo in cui tutti siamo pari. Non uguali, ma pari. Qualunque criterio che implichi superiorità o inferiorità rispetto ad un altro essere umano limita l’accoglienza e ancor più l’inclusione.
Il secondo è la reciprocità. Moltissimi si sono sentiti fin troppo spesso diversi, non accolti, e reclamano a gran voce l’inclusione. Richiesta più che legittima. Non vorrei, però, che dimenticassimo che essere accolti, sentirsi inclusi, è sì un diritto, ma implica la responsabilità di accogliere e includere.
Come ripeto spesso, non è questione di giusto o sbagliato, e non è neanche un inno ad un ipotetico buonismo. Si tratta di consapevolezza e scelte.
Quindi posso solo darti un consiglio, ed è lo stesso consiglio che ho ricevuto io nel mio primo giorno di lavoro da parte del general manager della multinazionale dove ero andata a lavorare: si è rivelato il miglior suggerimento che io abbia mai ricevuto nella mia vita.
“Ogni volta che incontri qualcosa di nuovo, e capiterà ogni giorno, cerca almeno tre analogie e tre differenze con ciò che conosci. Le analogie ti serviranno per essere più disponibile ad accogliere il nuovo e non fartene spaventare. Le differenze ti serviranno per non dare nulla per scontato e mantenerti sempre aperto ai cambiamenti utili. L’insieme di analogie e differenze ti permetteranno di scegliere consapevolmente cosa accettare e cosa rifiutare”

Non so come si insegni la storia oggi. Ai miei tempi, parecchi anni fa, la storia era una favola affascinante, ricca di personaggi, o una sequela di date: dipendeva dall’insegnante. Ma era sempre nettamente separata dall’educazione civica (che, bisogna dirlo, era piuttosto trascurata e, quando l’insegnante si ricordava, consisteva solo nella lettura della Costituzione: meglio di niente, ma troppo poco per educare dei cittadini). Certo, l'educazione civica è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di operare dello Stato, quindi non deve necessariamente preoccuparsi di sviluppare cittadini educati, ma solo informati. Non so neanche se l’insegnamento si chiami ancora Storia ed Educazione civica. Però credo che, attraverso l’insegnamento della Storia, si possano formare le coscienze, e migliorare la qualità di vita di tutti. La vittoria di Pirro ne è un bell’esempio . Sicuramente è importante spiegare che Pirro, re dell’Epiro, sfidò Roma, invadendo l’Italia nel terzo secolo avanti Cristo. In una delle battaglie (quella finale) i romani persero, ma causando tante e tali perdite all’esercito di Pirro che questi fu costretto ad abbandonare la guerra. Si possono aggiungere le date, spiegare la strategia militare, i nomi dei generali romani, e tutto quanto è compreso nel testo di storia, funzionale all’età dello studente. Ma si può anche cogliere l’occasione per spiegare che la definizione di “vittoria di Pirro” è rimasta nei modi di dire per evidenziare come una vittoria può equivalere ad una sconfitta . E da qui spiegare che non esiste solo la dicotomia vittoria – sconfitta, che non è indispensabile vincere o perdere. Se c’è un contrasto, se ci sono diversi punti di vista o diversi obiettivi, si può vincere insieme. Grazie a Pirro diventa più semplice spiegare quanto sono vane alcune liti, e quanto invece si può guadagnare con una negoziazione . Attenzione! Negoziazione, e non compromesso! Quando la guerra è in atto, al massimo si raggiunge un compromesso. Ma prima che la battaglia si scateni, che la lite raggiunga l’apice, si può tendere alla negoziazione: comprensione dell’altro e delle sue priorità e scelta di un obiettivo comune. Impossibile? Difficile? Complesso! Ma quanto si vive meglio! Questo è quanto scrivevo alcuni anni fa. Oggi, mai come oggi, è fondamentale ricordare il concetto della vittoria di Pirro. Oggi si combatte per vittorie immediate, con battaglie basate fondamentalmente sulla forza. Oggi si dimentica quanto siamo interconnessi e quanto la apparente sconfitta di uno diventa, in poco tempo, la sconfitta di tutti. A me sembra che i contendenti di oggi, e uno in particolare, stia precipitando verso una vittoria di Pirro, con gravi danni per tutti.